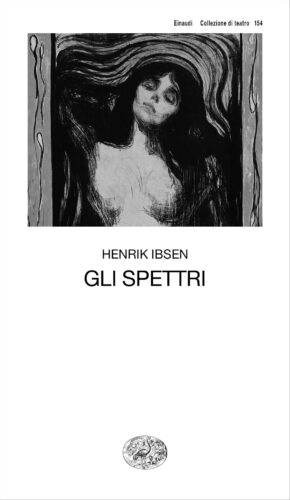 Sempre di grande stringente attualità il dramma di Ibsen andato in scena al Teatro Comunale di Udine, con un’interprete di grande rilievo nella parte della protagonista e una scenografia evocativa e all’altezza della situazione.
Sempre di grande stringente attualità il dramma di Ibsen andato in scena al Teatro Comunale di Udine, con un’interprete di grande rilievo nella parte della protagonista e una scenografia evocativa e all’altezza della situazione.
Andrea Jonasson è certo una dei grandi nomi del teatro italiano con una carriera eccellente che ormai si estende su sei decenni di frequentazione dei palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo e non serve dire del suo sodalizio con il Maestro Giorgio Strehler che contribuì a farne una stella di prima grandezza. La sua arte si è sempre connotata per un’algida freddezza e una presenza scenica spigolosa e spesso ruvida, il contrario di molte sue colleghe sempre carnose, burrose e sopra le righe.
La Jonasson, grazie a dio, non è mai stata niente di tutto questo e non lo è per nulla diventata con il trascorrere degli anni. Lo ha dimostrato ampiamente l’altra sera nella sua maiuscola interpretazione della signora Alvin del cupo dramma di Ibsen le cui atmosfere sembravano tagliate su misura per la sua interpretazione, anche se l’ultima scena l’ha vista velata come in una scena d’iconostasi, la sua più che una Mater lacrimosa sembrava la Nera Signora che tutti attende.
Soprattutto nel nostro paese la poetica di Ibsen è troppo spesso vittima di malintesi e stereotipi dovuti a sovra-interpretazioni o semplicemente a cattive traduzioni del testo che lo condannano ad una verbosità e ad una prosopopea ottocentesca modellata sulla sensibilità italiana d’allora, ma del tutto assente nei paesi scandinavi.
 Non è per nulla una questione di lana caprina o una fissazione da filologi oziosi, lo dimostra proprio la vicenda narrata in “Spettri” con il suo paradigmatico, significativo contrasto narrativo tra ambientazioni dal carattere uggioso, scuro e nordico e solarità mediterranea. “Mamma dammi il sole” sono infatti le ultime imploranti parole di Osvaldo, lo sfortunato figlio della protagonista minato nel fisico da un male ereditario aggravato dal piovoso clima dei fiordi occidentali della Norvegia.
Non è per nulla una questione di lana caprina o una fissazione da filologi oziosi, lo dimostra proprio la vicenda narrata in “Spettri” con il suo paradigmatico, significativo contrasto narrativo tra ambientazioni dal carattere uggioso, scuro e nordico e solarità mediterranea. “Mamma dammi il sole” sono infatti le ultime imploranti parole di Osvaldo, lo sfortunato figlio della protagonista minato nel fisico da un male ereditario aggravato dal piovoso clima dei fiordi occidentali della Norvegia.
Ibsen scrisse la sua tragedia durante un lungo viaggio in Italia che lo portò da Roma alla costiera amalfitana baciata da un sole fragoroso, quasi come ideale seguito del suo dramma epocale Casa di Bambola. Nel finale di quest’ultimo, Nora, moglie e madre borghese cresciuta e considerata nella casa avita della sua famiglia poco più di un complemento d’arredamento, si emancipa andandosene di casa e abbandonando marito e figli.
 La signora Alving in Spettri si pente gravemente di essersi fatta impietosire a tornare dopo l’iniziale allontanamento per il buon nome della famiglia e per il decoro. E’ stato il pastore Manders, amico di famiglia e per lei anche qualcosa di più, a convincerla, lo stesso che adesso deve forzatamente rendersi conto dell’orrore che quella scelta ha generato e che nemmeno il fuoco ormai può più purificare: “una donna non è autorizzata ad erigersi a giudice di suo marito. Era vostro dovere di sopportare umilmente la croce che la volontà dell’Altissimo aveva creduto bene d’imporvi. Invece voi vi siete ribellata, avete gettata lungi da voi la croce, abbandonando il poveretto ch’era vostra missione sostenere. Avete disertato, esponendo il vostro nome e la vostra riputazione, col rischio inoltre di rovinare la riputazione di qualche altro.”
La signora Alving in Spettri si pente gravemente di essersi fatta impietosire a tornare dopo l’iniziale allontanamento per il buon nome della famiglia e per il decoro. E’ stato il pastore Manders, amico di famiglia e per lei anche qualcosa di più, a convincerla, lo stesso che adesso deve forzatamente rendersi conto dell’orrore che quella scelta ha generato e che nemmeno il fuoco ormai può più purificare: “una donna non è autorizzata ad erigersi a giudice di suo marito. Era vostro dovere di sopportare umilmente la croce che la volontà dell’Altissimo aveva creduto bene d’imporvi. Invece voi vi siete ribellata, avete gettata lungi da voi la croce, abbandonando il poveretto ch’era vostra missione sostenere. Avete disertato, esponendo il vostro nome e la vostra riputazione, col rischio inoltre di rovinare la riputazione di qualche altro.”
 Sull’esistenza di ognuno, sembra volerci dire Ibsen, aleggia la maledizione di una colpa passata inemendabile che grava sulle coscienze e sui destini. Non si tratta di sicuro di una forma di “peccato originale” di tipo religioso, i cieli norvegesi dell’autore sono sconsolatamente vuoti e muti e nemmeno di una tara genetica di un vizio inconfessabile anche se in apparenza così sembra. E’ qualcosa di molto più radicale che apparenta Ibsen al contemporaneo nichilismo originato dalle opere di Schopenhauer. Anche se allora fu salutato come “naturalista” e più tardi come anticipatore delle tematiche simboliste, Ibsen è stato anche molto altro. Di certo ha affrontato tematiche tipiche della critica al mondo borghese che prefigurano quelle della psicoanalisi tra le più scabrose e inquietanti: dall’incesto, al rapporto genitori e figli svuotato di ogni contenuto morale fino alla vuota ipocrisia di ognuno degli individui che danno forma alla società e che non possono in alcun modo fare a meno della propria consustanziale decadenza. Le storture, i malanni e tutte le altre devianze, che minano la società borghese non sono altro che il frutto degli antichi vizi e delle menzogne attraverso i quali la medesima si è sostenuta nel corso dei secoli riuscendo a prevalere sulle altre classi che ha sottomesso.
Sull’esistenza di ognuno, sembra volerci dire Ibsen, aleggia la maledizione di una colpa passata inemendabile che grava sulle coscienze e sui destini. Non si tratta di sicuro di una forma di “peccato originale” di tipo religioso, i cieli norvegesi dell’autore sono sconsolatamente vuoti e muti e nemmeno di una tara genetica di un vizio inconfessabile anche se in apparenza così sembra. E’ qualcosa di molto più radicale che apparenta Ibsen al contemporaneo nichilismo originato dalle opere di Schopenhauer. Anche se allora fu salutato come “naturalista” e più tardi come anticipatore delle tematiche simboliste, Ibsen è stato anche molto altro. Di certo ha affrontato tematiche tipiche della critica al mondo borghese che prefigurano quelle della psicoanalisi tra le più scabrose e inquietanti: dall’incesto, al rapporto genitori e figli svuotato di ogni contenuto morale fino alla vuota ipocrisia di ognuno degli individui che danno forma alla società e che non possono in alcun modo fare a meno della propria consustanziale decadenza. Le storture, i malanni e tutte le altre devianze, che minano la società borghese non sono altro che il frutto degli antichi vizi e delle menzogne attraverso i quali la medesima si è sostenuta nel corso dei secoli riuscendo a prevalere sulle altre classi che ha sottomesso.
Nello specifico a partire da molti spunti autobiografici, Ibsen racconta di una ricca vedova (sig.ra Alving) che, poco prima di celebrare la memoria del marito ritenuto un esempio di virtù da tutta la comunità, rivela al proprio pastore (Manders) la dissolutezza del coniuge scomparso che l’ha fatta soffrire tutta la vita per i continui adulteri e gozzoviglie.
 Lei, da moglie fedele, a suon di menzogne è riuscita a mettere a tacere tutto per il bene del figlio (Osvaldo) che però si è innamorato della serva di casa (Regina) che non è altro che la sua sorellastra, frutto di una relazione del padre con una domestica che la moglie non ha voluto abbandonare. Lo stesso Ibsen ebbe un figlio da una relazione clandestina con una domestica. Il figlio tenuto all’oscuro di tutto, ha però ereditato dal padre la sifilide, essendo ormai in fase terminale e vuole che la madre ponga fine alle sue sofferenze. La madre, che per il figlio ha sacrificato tutta la propria dignità di persona, annullandosi a forza di inganni, comprende tragicamente l’assurda, dolorosa inanità del vivere. Il dramma finisce con questo dolore inestinguibile e sordo che rimane pesantemente sospeso e incombente; nessuno dei personaggi è completamente innocente, la corruzione interessa nel profondo quella società e non c’è alcuno spazio per la redenzione.
Lei, da moglie fedele, a suon di menzogne è riuscita a mettere a tacere tutto per il bene del figlio (Osvaldo) che però si è innamorato della serva di casa (Regina) che non è altro che la sua sorellastra, frutto di una relazione del padre con una domestica che la moglie non ha voluto abbandonare. Lo stesso Ibsen ebbe un figlio da una relazione clandestina con una domestica. Il figlio tenuto all’oscuro di tutto, ha però ereditato dal padre la sifilide, essendo ormai in fase terminale e vuole che la madre ponga fine alle sue sofferenze. La madre, che per il figlio ha sacrificato tutta la propria dignità di persona, annullandosi a forza di inganni, comprende tragicamente l’assurda, dolorosa inanità del vivere. Il dramma finisce con questo dolore inestinguibile e sordo che rimane pesantemente sospeso e incombente; nessuno dei personaggi è completamente innocente, la corruzione interessa nel profondo quella società e non c’è alcuno spazio per la redenzione.
Nel dramma non si risparmia alcun atteggiamento critico nei confronti della società borghese: incesto, eutanasia, famiglia allargate, adulterio, ipocrisia, inganni, ricatti, malattie veneree e chi più ne ha più ne metta.
“Sig.ª Alving. Ascoltatemi, e sappiate com’io la pensi. Io sono timida, ho paura, perché c’è in me qualche cosa…. qualche cosa che mi opprime, dei ricordi terribili che mi afferrano come spettri da cui non posso liberarmi.
 Il Past. Come avete detto, signora Alving?
Il Past. Come avete detto, signora Alving?
Sig.ª Alving. Quando intesi là, Regina ed Osvaldo, mi parve ad un tratto che tutto il passato mi si rizzasse innanzi. Ma io sto quasi per credere, Pastore, che noi siamo tutti spettri. Non è soltanto il sangue dei nostri genitori che corre in noi, ma c’è inoltre una specie d’idea distrutta, una credenza morta, e tutto ciò che ne risulta, e questo non è vitale, è vero, ma ciò nulla meno se ne sta in fondo a noi stessi, e mai non riusciamo a liberarcene. S’io prendo un giornale e mi metto a leggere, ecco sorgermi dei fantasmi tra linea e linea. Mi sembra quasi che tutto il paese sia popolato di fantasmi, e che questi siano numerosi come le arene del mare. E poi tutti noi, quanti siamo, abbiamo tanta paura della luce!”
Il testo “contratto” e la messa in scena a cura di Fausto Paravidino fanno risultare il dramma una vera e propria riduzione che però non ne snatura i fondamentali significati. A partire anche dalla regia di Rimas Tuminas e dalla scenografia di Adomas Jacovskis che evocano un’atmosfera perennemente immersa nella caligine della nebbia che fa sembrare i protagonisti davvero delle figure dell’oltretomba. L’impressione generale è proprio che si tratti di una casa di morti condannati a ricordare in eterno la propria disgrazia.
A stonare l’interpretazione tutta sopra le righe di Eleonora Panizzo (Regine) e quella di Gianluca Merolli (Osvald), entrambi sono sembrati completamente fuori contesto, lei animata da una gioia fanciullesca, lui da un dolore un po’ fasullo. Poco più che comparse sono apparsi Fabio Sartor (Manders) e Giancarlo Previati (Engstrand).
 Non si può certo dire che lo spettacolo brilli per le dinamiche delle sue azioni o per essere avvincente, ma funziona ugualmente con tutti i suoi silenzi e le sue sconsolate esitazioni accentuati da una colonna sonora spesso invasiva e tetramente ossessiva.
Non si può certo dire che lo spettacolo brilli per le dinamiche delle sue azioni o per essere avvincente, ma funziona ugualmente con tutti i suoi silenzi e le sue sconsolate esitazioni accentuati da una colonna sonora spesso invasiva e tetramente ossessiva.
Evidentemente tutto è stato calibrato sulla prestazione della Jonasson che non delude nemmeno quelli che la considerano accademica e legnosa. Quello che davvero stupisce e che fa vacillare antiche convinzioni sul reale potere catartico del teatro è il fatto che dopo più di cento anni che si rappresentano le opere di Ibsen con la loro acuta disamina e feroce condanna della falsità della società borghese, niente è cambiato e continua imperterrito a stritolare le coscienze e a fare a pezzi la nostra dignità, vendendo e comprando la nostra mala fede per i soliti sporchi trenta denari.
© Flaviano Bosco – instArt 2023
