
Sanchez nelle interviste ripete molto spesso che di ogni suo nuovo lavoro spera non si dica “è il disco o il progetto di un batterista” ma semplicemente musica. Con tutta la buona volontà è davvero difficile non notare la profonda impronta del suo indiscutibile talento e della sua tecnica inaudita sia nelle sue incisioni, sia a maggior ragione dal vivo.
 E’ un percussionista dalle poliritmie assolutamente uniche, le dinamiche che riesce a creare con le bacchette sono talmente estreme e inusuali che lo distinguono fin dalle prime battute. E’ così anche per il quartetto di All Stars con il quale si è presentato a Villa Varda di Brugnera (PN) dove da anni si tiene un prestigioso e ricercato festival blues con proposte sempre raffinate e appaganti.
E’ un percussionista dalle poliritmie assolutamente uniche, le dinamiche che riesce a creare con le bacchette sono talmente estreme e inusuali che lo distinguono fin dalle prime battute. E’ così anche per il quartetto di All Stars con il quale si è presentato a Villa Varda di Brugnera (PN) dove da anni si tiene un prestigioso e ricercato festival blues con proposte sempre raffinate e appaganti.
Ma per non limitarsi alla solita retorica da giornaletto facciamo il punto sull’identità degli artisti che hanno accompagnato il batterista messicano.
Donny McCaslin (sax tenore). Molto atteso da una parte del pubblico per i suoi trascorsi con David Bowie non ha per niente indugiato in nostalgie. In questo progetto ad essere protagonista è il suo sassofono e la sua indubbia capacità di soffiarci dentro splendidi accordi. Il capolavoro con la stella nera era alla base della recente esibizione al Torino Jazz Festival del suo Bowie’s Blackstar 4et con la splendida bassista Gail Ann Dorsey. In questo caso, lo strumento di McCaslin è stato al più completo servizio del batterista messicano senza però dimenticare la sua eclettica formazione di musicista in grado di spaziare dall’alternative rock, al prog-jazz, al punk fino alla psichedelia. Per comprendere la sua poliedricità creativa, si ascolti l’ultimo suo lavoro “Blow” (2018) un vero caleidoscopio di suoni affascinanti ed energie eterodosse.
Miguel Zenon (sax contralto). Di origine portoricana ha sviluppato nel corso degli anni con il proprio strumento uno stile unico e particolare che fonde la tradizione del jazz creolo e caraibico con quella della migliore avanguardia newyorkese ed europea. Come ha dichiarato in un’intervista a Downbeat: “Rappresenta le mie radici, le fondamenta del mio essere portoricano. Nella mia musica l’elemento folklorico è molto potente. Il popolo vi si identifica anche se non l’ha mai sentito prima. E’ un’eredità delle generazioni, è qualcosa che viene dalla madre terra”.
A parte le tantissime collaborazioni fuori e dentro il jazz, davvero rimarchevole è la sua attività filantropica e di formatore con la musica rivolta in particolare ai più fragili e dimenticati della comunità portoricana di New York e dell’isola, ufficialmente, “territorio non incorporato” degli Stati Uniti. Solo per fare un esempio, nell’album dal titolo suggestivo di “Identities Are Changeable”, con un lavoro da vero etnomusicologo, mescola interviste sul campo nei quartieri più poveri di San Juan, Portorico ai suggestivi commenti musicali del suo gruppo.
 Scott Colley (contrabbasso). Accreditato come “uno dei più importanti bassisti della postbop era, compositore e band leader risoluto e prolifico” come ha scritto il New York Times con una discografia sterminata che conta centinaia di incisioni e partecipazioni. A guidarlo sembra essere un’inesauribile creatività e continua volontà di ricerca in ogni ambito musicale, supportato da una tecnica che è stata definita “empatica e dal grande senso melodico e abilità d’improvvisazione”. Dotato di una ritmica che sa essere dolcissima ma anche rigida, precisa, ossessiva, rigorosa e quasi ossea, vertebrale non concede nulla al caso ma esplora secondo schemi di improvvisazione dalla logica ferrea, anche se sembra una contraddizione in termini.
Scott Colley (contrabbasso). Accreditato come “uno dei più importanti bassisti della postbop era, compositore e band leader risoluto e prolifico” come ha scritto il New York Times con una discografia sterminata che conta centinaia di incisioni e partecipazioni. A guidarlo sembra essere un’inesauribile creatività e continua volontà di ricerca in ogni ambito musicale, supportato da una tecnica che è stata definita “empatica e dal grande senso melodico e abilità d’improvvisazione”. Dotato di una ritmica che sa essere dolcissima ma anche rigida, precisa, ossessiva, rigorosa e quasi ossea, vertebrale non concede nulla al caso ma esplora secondo schemi di improvvisazione dalla logica ferrea, anche se sembra una contraddizione in termini.
Dovrebbe essere ormai chiaro che nel jazz come in tutti gli altri generi musicali al massimo grado dell’improvvisazione non corrisponde per niente il kaos ma quel preciso straordinario momento che bisogna saper cogliere nel quale il tempo scandito si trasforma in opportunità creativa dilatando le sue prospettive. Dominare quell’attimo con la sola forza delle dita e del cervello per un contrabbassista è il non plus ultra.
Come ha detto al pubblico il grande batterista in uno scherzoso “ital-gnolo” durante il concerto “non è per niente facile suonare con una band di musicisti all-stars di questa grandezza, tutti leader di proprie formazioni” con curricula e collaborazioni da far tremare i polsi come abbiamo avuto modo di vedere.
Non si può pretendere di annullare in un istante la personalità artistica di ognuno di loro se non a prezzo di qualche indesiderato ma quasi inevitabile asperità esecutiva.
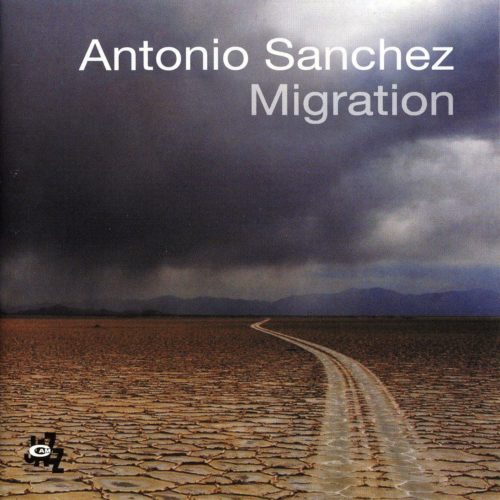 Inizialmente, il sound complessivo del quartetto è apparso fin troppo solido e legnoso da lasciare un po’ perplessi per l’intransigenza e l’irruenza della sezione ritmica. Il primo brano, pur basato quasi interamente su una lunghissima improvvisazione modale del sax alto, risultava accademico e eccessivamente strutturato. Lo spazio delle ance era esattamente calibrato su quello che la ritmica concedeva loro, i due sax sembravano, è proprio il caso di dirlo, comandati a bacchetta in un’esecuzione a spartito; continuamente costretti ad inseguire la debordante ipertecnica metronomia delle percussioni e del contrabbasso. Una continua riproposizione di virtuosismi muscolari e di preziosismi strumentali da far girare la testa ma che sembravano fine a se stessi.
Inizialmente, il sound complessivo del quartetto è apparso fin troppo solido e legnoso da lasciare un po’ perplessi per l’intransigenza e l’irruenza della sezione ritmica. Il primo brano, pur basato quasi interamente su una lunghissima improvvisazione modale del sax alto, risultava accademico e eccessivamente strutturato. Lo spazio delle ance era esattamente calibrato su quello che la ritmica concedeva loro, i due sax sembravano, è proprio il caso di dirlo, comandati a bacchetta in un’esecuzione a spartito; continuamente costretti ad inseguire la debordante ipertecnica metronomia delle percussioni e del contrabbasso. Una continua riproposizione di virtuosismi muscolari e di preziosismi strumentali da far girare la testa ma che sembravano fine a se stessi.
Che fosse un’impressione sbagliata lo si è cominciato a capire dall’improvvisazione sul brano Medusa, un’incredibile lunga suite che si è aperta con un interessante, energico contrasto tra la batteria e il contrabbasso. E’ stato un deciso cambio di passo e la musica del gruppo ha cominciato ad esprimere le inquietudini, le suggestioni sofferte e la mestizia dei lavori discografici di Sanchez, politicamente schierato contro le persecuzioni agli immigrati negli Stati Uniti così come Zenon e gli altri.
Il primo album a suo nome, “Migration”, del 2007 che aveva visto la straordinaria partecipazione di Chick Corea, Chris Potter, Pat Metheny e lo stesso contrabbassista Scott Colley era una violenta, risoluta, militante denuncia contro la politica xenofoba e criminale dell’amministrazione Trump che aveva nel famigerato muro con il Messico il suo punto propagandistico di forza.
Nelle registrazioni di allora anche le voci dei profughi torturati e abusati dalla polizia di frontiera americana e dai “minute-man”. Con la nuova amministrazione Biden le cose sono cambiate solo nominalmente, basta vedere l’attacco frontale rivolto in queste ultime settimane contro il regime democratico di Cuba, ancora una volta in una surreale e anacronistica crociata anticomunista.
A partire da queste dichiarate intenzioni libertarie, appare molto più chiara la direzione della musica di Sanchez e dei suoi pari. Ancora una volta il jazz diventa politico sotto le apparenze di una musica troppo sofisticata e tecnica per essere compresa. Come diceva un poeta: “Non dobbiamo per forza capire la musica, dobbiamo sentirla”. Con la pubblicazione dell’album “Free jazz: A Collective Improvisation” di Ornette Coleman nel 1961 la musica di ispirazione afroamericana cambiò decisamente non solo nei registri e nelle tonalità ma anche nel significato. Non era più solamente espressione di un’identità o di una piacevole particolare estetica. Suonare allora diventava un atto politico, rivoluzionario che aveva l’intenzione, attraverso suoni non convenzionali e composizioni a schema libero, di denunciare le ingiustizie e i soprusi ed esortare quanto meno alla riflessione interiore sui temi dell’uguaglianza e della libertà.
E’ proprio questo che hanno voluto fare Sanchez e i suoi musicisti, certo senza alcuna ostentazione o proclama diretto ma con la testimonianza delle forme musicali che eseguivano.
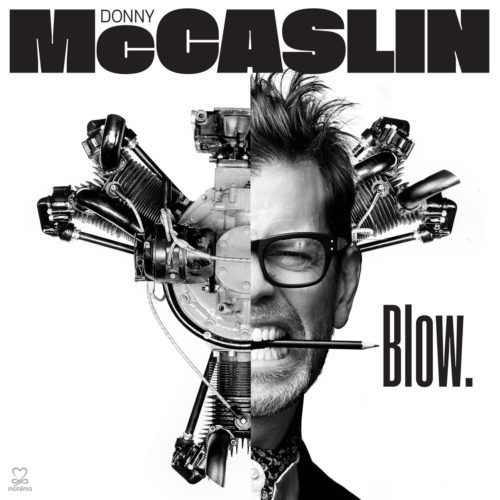 In questo senso, le ance che inizialmente apparivano quasi “incatenate” alle geometriche, granitiche ritmiche assumono il significato di metafora ed esprimono le dinamiche di sopraffazione tra il potere poliziesco e squadrista dei paesi ricchi e le voci di quei deboli che il tallone di ferro della politica schiaccia. Se questa interpretazione apparisse fantasiosa o forzata si consiglia l’ascolto del materiale audio, ai quali già accennavamo, che su disco e nei precedenti tour di Sanchez veniva associato ai brani e a volte ai singoli strumenti, quasi fossero le voci di quei miseri che finivano nei campi di concentramento solo per aver voluto varcare un confine in cerca di speranza.
In questo senso, le ance che inizialmente apparivano quasi “incatenate” alle geometriche, granitiche ritmiche assumono il significato di metafora ed esprimono le dinamiche di sopraffazione tra il potere poliziesco e squadrista dei paesi ricchi e le voci di quei deboli che il tallone di ferro della politica schiaccia. Se questa interpretazione apparisse fantasiosa o forzata si consiglia l’ascolto del materiale audio, ai quali già accennavamo, che su disco e nei precedenti tour di Sanchez veniva associato ai brani e a volte ai singoli strumenti, quasi fossero le voci di quei miseri che finivano nei campi di concentramento solo per aver voluto varcare un confine in cerca di speranza.
La convinzione di musicisti come quelli dello Special 4et, per quanto utopico e velleitario possa sembrare, è che, affinando la sensibilità di ognuno, sia possibile combattere le ingiustizie che ci affliggono che, se è possibile, la gestione dell’epidemia ha moltiplicato all’inverosimile.
Da questa prospettiva risultano più comprensibili i furiosi cambi di tonalità, le composizioni in più movimenti o sottosezioni che ricordano i ritmi di una concitata narrazione, il martellare della batteria e la sostenuta enfasi di alcuni momenti che evocano paesaggi desertici percorsi da disperazione, illuminati solo dai fuochi dei bivacchi e dai lampi dei traccianti.
Il suono del quartetto, inizialmente criptico e contratto, è diventato via via magmatico e sulfureo non senza avere espresso nel mentre qualche abrasiva ruvidezza.
Negli ultimi brani, di certo in omaggio al festival, il quartetto si è impegnato in atmosfere e soluzioni armoniche tipicamente blues, liriche, espanse, dilatate senza però tralasciare una scura tonalità melodrammatica appena nascosta dalla robustezza dei ritmi.
Come diceva uno dei più grandi percussionisti della storia della musica contemporanea, Babatunde Olatunji:
“Lo spirito della percussione è qualcosa che si può sentire ma che non si può afferrare, ti fa qualcosa che ti entra dentro…Colpisce la gente in modi diversi. Ma la sensazione che si prova è di soddisfazione e di gioia. E’ uno stato d’animo che ti fa dire a te stesso: “Sono felice di essere vivo oggi! Sono felice di essere parte di questo mondo!”
© Flaviano Bosco per instArt
